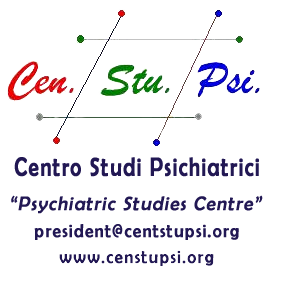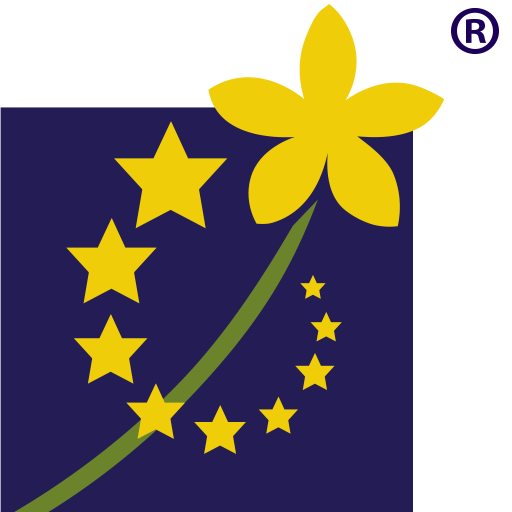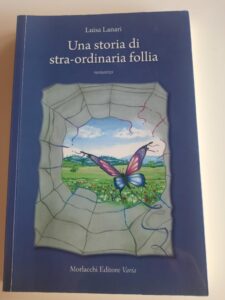Introduzione
Il 2025 ha visto fin dal principio giungere notizie e immagini poco rincuoranti, se possibile ancora più cupe e preoccupanti di quelle degli anni precedenti, che non accennano a diminuire. La guerra in Gaza, Ucraina, Sud Sudan, Afghanistan, Iran, Haiti…l’elenco è lungo e incompleto. Il pianeta sta bruciando, come dice Greta (Thunberg ndr), e non solo per motivi climatici. Guerre e conflitti sono sempre più diffusi e ricorrenti, tanto che vengono in mente le parole di Papa Bergoglio, quando parlava del rischio di una “III Guerra mondiale a pezzi”.
Gli operatori umanitari e sanitari in prima linea nella emergenza sono sicuramente molto esposti a rischi psicologici nel prestare i proprio soccorsi in scenari di guerra. Per tale motivo hanno nel loro curriculum formazioni imprescindibili alla gestione del trauma emotivo.
Vengono poco considerate tuttavia le conseguenze psicologiche che sussistono anche per i comuni cittadini, esposti tramite i mass media alle notizie dai fronti di conflitto.
Esperienze traumatiche croniche possono facilitare l’insorgenza di disturbi psichici rilevanti quali ansia, depressione, PTSD (disturbo post traumatico da stress) e moral distress, anche in chi vi assiste indirettamente. Oppure all’opposto si corre il rischio di sviluppare reazioni di disumanizzazione e cinismo difensivo, che a loro volta esercitano un impatto negativo sulla salute mentale complessiva della popolazione.
Conseguenze psicologiche della guerra: distress morale e disumanizzazione
Il termine moral distress fu introdotto da Jameton nel 1984 in ambito infermieristico. È utilizzato per descrivere una condizione dove l’individuo sa quale sia l’azione eticamente corretta, ma è impossibilitato a compierla per vincoli istituzionali, normativi o pratici. Sebbene il termine sia nato in ambito professionale, negli ultimi anni è stato esteso anche ai civili esposti a scelte impossibili o all’impotenza morale.
Davanti a immagini di civili inermi uccisi da bombe e cecchini, sottoposti a continue violenze, o portati alla morte da fame e privazioni, tutti soffriamo. Proviamo il desiderio di proteggere i più deboli, in particolare i bambini. Tuttavia, oggigiorno si avverte una profonda distanza tra il comune sentire dei cittadini e le azioni dei governi, guidati da logiche economiche e politiche differenti. Questa distanza apparentemente incolmabile acuisce il rischio di sviluppare ansia, cinismo e moral distress.
Le conseguenze psicologiche del moral distress, accompagnate da sentimenti di impotenza, colpa, vergogna, se non compensate, portano a sviluppare disturbi quali depressione o burnout professionale. La continua esposizione a un generale senso di ineluttabilità e ingiustizia può indurre la persona a percepirsi come soverchiata da forze superiori alle sue capacità. Emergono vissuti di tristezza, paura e sfiducia nell’altro e nel futuro. In poche parole, la depressione.
In altri casi l’esposizione protratta al trauma altrui (trauma vicariante) conduce ad interiorizzare il trauma altrui come se fosse proprio. Questo stato emotivo così penoso può portare per reazione ad una sorta di disconnessione morale in cui tutto perde di significato. Ci si rifugia nel cinismo difensivo (“è sempre stato così…non cambia mai nulla …”) e nella disumanizzazione (“sono questioni che non mi riguardano…non c’entro”). Entrambe queste reazioni costituiscono una condizione psicologica pericolosa, dove l’orizzonte dei valori etici e morali della società si fa confuso e indefinito.

Depressione, foto di Luigi Starace, 2024
Moral distress e disumanizzazione: impatto della guerra nella collettività
Il distress morale di fronte alla guerra si accompagna frequentemente ad una generale crisi di senso. Dopo aver assistito a livelli estremi di distruzione e violenza, disumana e disumanizzante, molte persone sviluppano una sorta di disorientamento esistenziale. Ci si chiede che significato abbia il proprio lavoro o la propria esistenza. Le convinzioni su ciò che è giusto o sbagliato si frantumano.
La disumanizzazione a sua volta riduce la disponibilità all’aiuto individuale e collettivo. Le persone sono in generale portare a rivedere la propria disposizione ad avvicinarsi all’altro, e ad aiutarlo. Diminuisce l’empatia, la capacità di provare ciò che l’altro vive. L’esposizione continua al trauma e alla violenza mediatica crea paura, cinismo e sfiducia nelle istituzioni e nel mondo. Si rinforza una cultura individualistica, dove il rispetto e la cura dell’altro passano in secondo piano. Si rinforzano in compenso valori di natura narcisistica (“pensa a te… oggi ci siamo domani chissà…mi faccio i fatti miei”).
La guerra e i giovani, quale futuro per loro?
Consideriamo ad esempio i ragazzi oggi, immersi in un mondo digitale parallelo fatto di immagini, video, social e relazioni improntate alla competizione e alla apparenza. Essere testimoni di ingiustizie e sofferenze imposte, senza limite né condanna ufficiale, può sollecitare in loro la percezione che tutto è ammesso, giustificabile, o indifferente. Homo homini lupus recitavano gli antichi. Un tale messaggio, diffuso tramite la possibilità di assistere indirettamente agli avvenimenti nei luoghi di conflitto, dove conduce le nuove generazioni in futuro? Che “lezione morale” stanno imparando? A parole sentono parlare di diritti, legge e rispetto per la persona. Nei fatti però vivono ogni giorno il prevalere di interessi economici e personali che cancellano diritti umani fondamentali. Cosa possiamo aspettarci da loro in futuro?
Già oggi vediamo giovani che per un like investono bambini alla guida di macchine di lusso, guidate a folle velocità. Ragazzi che di fronte a una frustrazione arrivano a uccidere di impulso i propri genitori o fidanzate, con una scioccante indifferenza. Siamo certi che questa sorta di “anestesia emotiva collettiva” che riscontriamo nel mondo non abbia nulla a che fare con quanto accade intorno a noi? Dentro di noi?
Guerra, distress morale e disumanizzazione. Strategie di contrasto
Una dinamica emotiva, individuale e collettiva, così impattante e complessa può essere affrontata solo in modo corale e con azioni operanti su più piani. Esistono scelte individuali di cura che la persona può intraprendere, per trovare sollievo al suo disagio, tramite interventi psicologici specifici. EMDR, logoterapia, interventi gruppali. Sul piano comunitario sono altrettanto necessari interventi psicosociali di comunità volti a riprendere, sviluppare e curare le competenze emotive, psicologiche e morali della collettività.
Una opportunità prioritaria di intervento passa attraverso l’educazione e la sensibilizzazione emotiva generale. Coltivare il senso morale, il rispetto dell’altro e la consapevolezza sul proprio sentire è oramai un imperativo etico e sanitario. Troppo forte e diffuso è infatti il bisogno, specie nelle giovani generazioni, di ritrovare un senso e un ancoraggio profondo alla vita oggi.
Facilitare la narrativa personale, il racconto di sé, in contesti non giudicanti e supportivi, come possono essere gruppi di auto aiuto è di cruciale importanza. In generale favorire qualsiasi occasione sociale dove reimparare l’arte dell’ascolto e del dialogo, abbandonando i cosiddetti “leoni da tastiera”, è una buona strada da percorrere. Gruppi di parola e narrazione collettiva (narrative exposure therapy, testimoni di pace) possono essere utili in tal senso.
È possibile cercare di sviluppare una sorta di “riparazione morale”, attraverso forme simboliche di testimonianza e riconoscimento del trauma. Si sostiene la ricostruzione di significati condivisi, ad esempio attraverso memoriali, cerimonie simboliche, rituali.
Un tentativo di riparazione del trauma è realizzabile, ove possibile, anche promuovendo la partecipazione attiva delle vittime alla ricostruzione. O cercando di restituire voce e agency a chi subisce violenza e sopraffazione, attraverso l’arte, la testimonianza, la scrittura. Il ripristino autentico e non formale della dignità e dei principi etici e morali fondamentali, nel riconoscimento collettivo, è il passo imprescindibile di questo cammino.
Guerra e mass media
Sviluppare una decisa attenzione etica e professionale dei media ai contenuti da diffondere e alle modalità per farlo può giocare un ruolo decisivo. Ciò evitando rischi di censura mediatica da una parte e sensazionalismo manipolativo o disumanizzante dall’altro. Per altro educare la popolazione, ed in particolare le giovani generazioni, al consumo critico delle informazioni e alla “decostruzione visiva” dei media ha un’importanza strategica.
Conclusioni
Il mondo attuale sta vivendo anni difficili, di conflitti geopolitici diffusi, guerra, violenza, catastrofi umanitarie ripetute. L’esposizione continua, seppur indiretta, a ingiustizie e abusi può ingenerare sofferenza emotiva e moral distress nelle persone sensibili, o all’opposto anestesia emotiva e disumanizzazione. Entrambe sono fenomeni psicologici potenzialmente tossici per la salute mentale della collettività.
La disumanizzazione non è solo un fenomeno retorico, ma ha effetti misurabili sulla salute mentale, e sulle capacità di empatia e solidarietà della collettività. Ovviamente ha profonde ripercussioni sociali e politiche. La disumanizzazione che avviene nelle guerre non è solo una scelta individuale, ma una ferita al tessuto sociale. Contrastarla sul piano sociale significa coltivare empatia pubblica, rafforzare la coesione sociale, e creare una cultura della responsabilità emotiva condivisa. Tutto ciò richiede un impegno collettivo su più livelli, dove istituzioni, stakeholders (portatori d’interessi), associazioni e comuni cittadini sono tutti chiamati a dare il proprio contributo.
Wilma Di Napoli
Bibliografia
- Agamben, G. Homo Sacer. Ed Quodlibet. 2021
- Herman, J. L. (1992). Trauma and Recovery. Ed Magi 2005.
- Molnar, B. E., et al. (2017). “Advancing science and practice for vicarious traumatization/secondary traumatic stress: A research agenda.” Trauma, Violence, & Abuse, 18(3), 346–356.
- Rushton, C.H. (2018). Moral Resilience: Transforming Moral Suffering in Healthcare.
- Shay, J. (2014). Moral injury. Psychoanalytic Psychology, 31(2), 182–191
- WHO (2023). Mental Health in Emergencies: Civilian Needs and Long-term Support.
Foto: Envato Elements
Foto: Depressione, foto di Luigi Starace, 2024