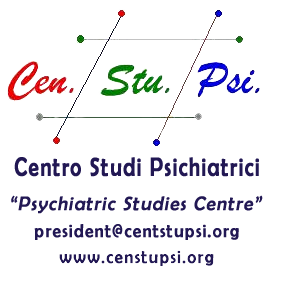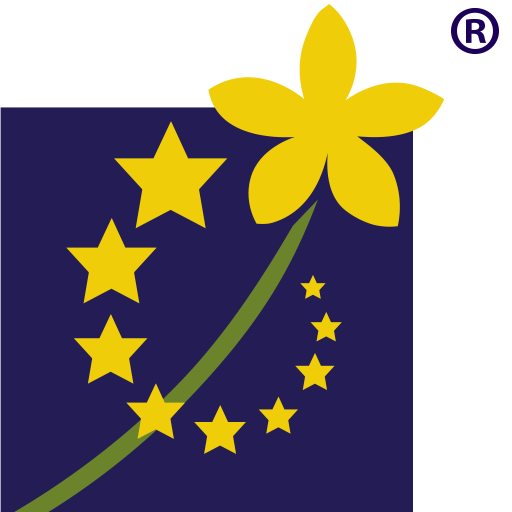Procrastinare: un meccanismo emotivo
Procrastinare o rimandare un compito importante non è segno di pigrizia, ma una modalità frequente di regolazione emotiva. Secondo Sirois (2007), si evita un’azione non perché priva di senso, ma perché genera disagio: ansia, paura di fallire, frustrazione.
Secondo la teoria della motivazione temporale (Steel & König, 2006), tendiamo a procrastinare perché preferiamo una gratificazione immediata. Scegliamo, ad esempio, di guardare una serie TV o scorrere i social a un compito meno piacevole ma importante. Questo accade perché il valore di una ricompensa futura diminuisce quanto più è lontana nel tempo (“delay discounting”).
Chi procrastina sperimenta spesso un senso crescente di ansia, che si intensifica con l’avvicinarsi della scadenza. Questo ciclo può generare frustrazione, senso di colpa, vergogna e un progressivo calo dell’autostima (Flett et al., 2016).
Il sollievo provato nel completare il compito all’ultimo minuto funziona come un potente rinforzo negativo, che consolida l’abitudine del rimando. Evitiamo il compito per sfuggire all’ansia, e finiamo per rinforzare proprio ciò che la alimenta. In realtà, l’ansia cresce man mano che la scadenza si avvicina, finché non raggiunge un livello tale da spingere all’azione. È in quel momento che il ciclo si ripete, rinforzando l’idea che si può funzionare solo sotto stress (Tice & Baumeister, 1997).
Si sceglie allora una gratificazione immediata – guardare il telefono, sistemare qualcosa – al posto dell’attività impegnativa. Il sollievo provato rafforza questa scelta (Flett, Haghbin & Pychyl, 2016), innescando un circolo vizioso. Il compito viene evitato finché la pressione non diventa ingestibile, e solo allora si agisce.
Procrastinare in adolescenza: identità in costruzione
L’adolescenza è una fase delicata, in cui si è chiamati a costruire una visione di sé, a distinguersi dagli altri e a compiere scelte sempre più autonome. In questo contesto, procrastinare può assumere una funzione protettiva. Rinviare un compito o una decisione permette di prendere tempo, mantenere un senso di controllo e allontanare il rischio di fallire o deludere.
Durante l’adolescenza, il rimandare può diventare una difesa contro l’ansia da prestazione o da giudizio. Molti ragazzi alternano momenti di iperattività ad altri di blocco e ritiro. Beutel et al. (2016) infatti, spiegano che procrastinare protegge l’identità: si rinvia ciò che può farci sentire inadeguati. Questo è tipico in ragazzi perfezionisti, che pensano: “se non lo faccio perfettamente, meglio non farlo”.
In questa fase, il rimandare può avere molte funzioni: evitare delusioni, sfuggire a pressioni familiari o scolastiche, mantenere il controllo. Ma se diventa cronico, può portare a vissuti depressivi, ritiro sociale e scolastico, sensazione di inefficacia.
L’adulto procrastinatore: tra efficienza e blocco
Molti adulti rimandano scelte o attività importanti pur essendo funzionali in altri ambiti. Il procrastinare diventa una strategia per evitare emozioni spiacevoli e conservare un’identità stabile anche se insoddisfacente. Il rimandare non è solo disorganizzazione, ma una forma di protezione: cambiare lavoro, affrontare un conflitto, o iniziare una terapia può sembrare minaccioso.
Il perfezionismo, secondo Steel e König (2006), è un fattore cruciale: più il sé ideale è elevato, più si teme di non essere all’altezza. Per chi ha vissuto il rimando con vergogna fin da giovane età, l’adulto può portare dentro di sé l’etichetta di inconcludente, rafforzando l’evitamento.
Il significato soggettivo del rimandare
Dal punto di vista clinico, la procrastinazione segnala un conflitto tra il desiderio di agire e la paura del cambiamento. Spesso si accompagna a un dialogo interno rigido: “non valgo nulla”, oppure “non è il momento giusto”.
Nell’approccio costruttivista post-razionalista (Guidano, 1991), questo comportamento viene letto come espressione di un’organizzazione interna che tenta di mantenere coerenza, anche a costo di sacrificare l’azione. Arciero e Bondolfi (2009) sottolineano che l’agire è influenzato dalla percezione soggettiva del tempo, del valore personale e della “coerenza narrativa del sé”.
Superare davvero il procrastinare
Le strategie comportamentali – come suddividere i compiti o ridurre le distrazioni – sono utili, ma non risolutive se non si lavora sul significato emotivo del compito evitato. Foroux (2024) suggerisce di chiedersi: “Perché lo sto facendo?”. Il legame con la motivazione personale è più efficace di qualsiasi promemoria.
Van Eerde e Klingsieck (2018), in una metanalisi, indicano che gli interventi più efficaci integrano aspetti emotivi, cognitivi e relazionali. In psicoterapia quindi, il rimandare può diventare il punto di partenza per esplorare l’identità, riformulare il perfezionismo e costruire un senso di sé più flessibile.
Conclusioni
La procrastinazione non è un vizio da correggere, ma un messaggio da comprendere. È il segnale di un conflitto tra sicurezza e cambiamento, tra ciò che si sente e ciò che ci si aspetta da sé. In adolescenza come in età adulta, può cronicizzarsi se non viene ascoltata. Il giovane che rimanda non è semplicemente distratto o pigro. Sta cercando, spesso inconsapevolmente, di capire chi è, cosa vuole, e come può rispondere alle richieste del mondo senza perdere sé stesso.
Alcune persone riferiscono di procrastinare da sempre, come se ci fosse “una parte di sé” che teme di agire. Questo blocco, se letto in profondità, può raccontare una difficoltà nel riconoscere e regolare le proprie emozioni, oppure nel tollerare l’incertezza legata al cambiamento.
Un percorso psicoterapeutico consente di rileggere il rimando non come un errore, ma come il bisogno di coerenza, protezione e senso. Solo riconoscendone le radici emotive si può trasformare il blocco in possibilità di crescita.
Antonella Vacca
Bibliografia
- Amarnath A. et al. (2023). Internet Interventions, 32, 100612.
- Arciero G., Bondolfi G. (2009). Selfhood, Identity and Personality Styles. Wiley-Blackwell.
Beutel M.E., Klein E.M., Brähler E. et al. (2016). PLOS ONE, 11(2).
Flett A.L., Haghbin M., Pychyl T.A. (2016). Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 34, 169–186. - Foroux D. (2024). Fallo oggi. Milano: Apogeo.
- Guidano V.F. (1991). The Self in Process. New York: Guilford Press.
- Sirois F.M. (2007). Personality and Individual Differences, 43(1), 15–26.
- Steel P., König C.J. (2006). Academy of Management Review, 31(4), 889–913.
- Tice D.M., Baumeister R.F. (1997). Psychological Science, 8(6), 454–458.
- Van Eerde W., Klingsieck K.B. (2018). Educational Research Review, 25, 73–85.
Sitografia
APA Stress Survey (2014): https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2014/stress-report
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8634399/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8634399/
Foto: Envato Elements