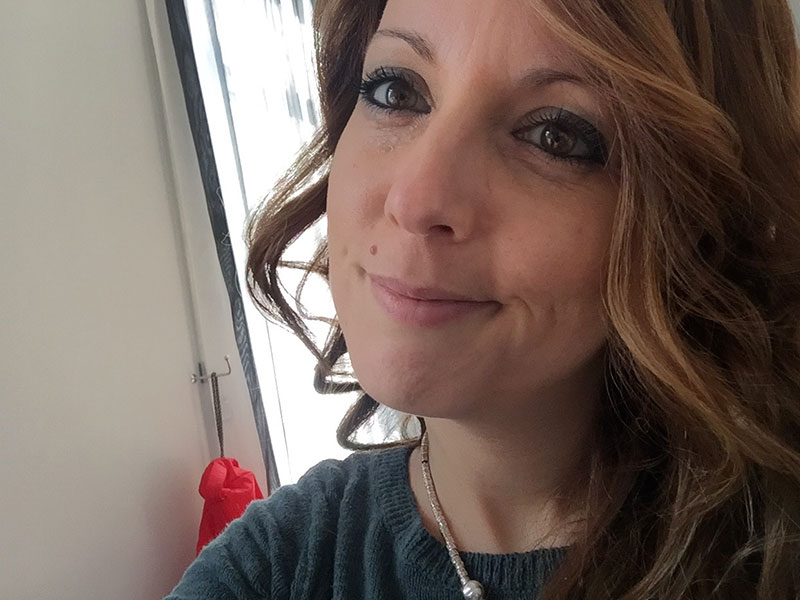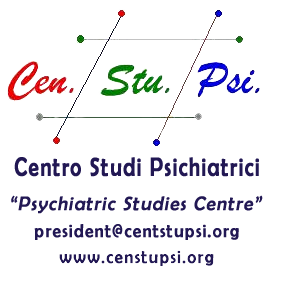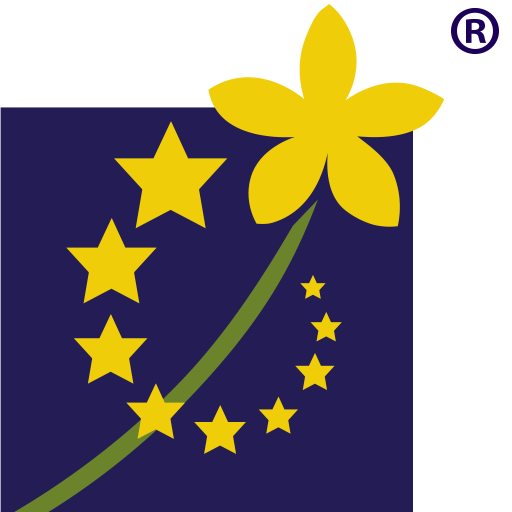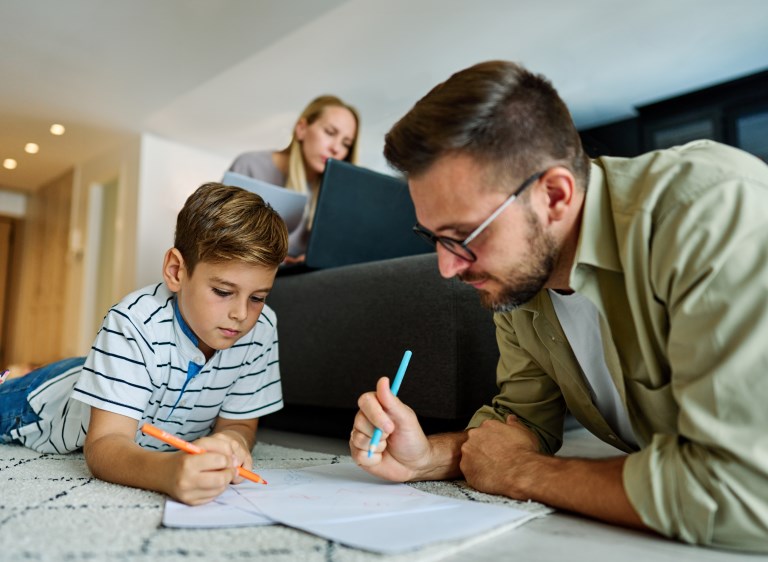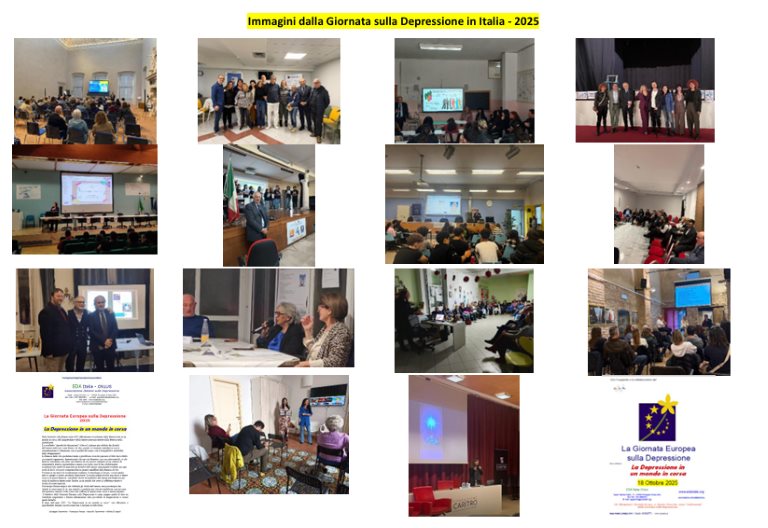Introduzione
È giusto aiutare i propri figli per i compiti a casa? Rispetto a questa domanda eserciti di mamme super esperte si dividono in gruppi diversi che scatenano guerre accese su WhatsApp in merito all’autonomia dei figli. “Devono sbagliare, sennò non imparano mai” … “Non saranno mai autonomi”. ” Ero esausta, alla fine glieli ho fatti io!” … Ma la maestra non ha spiegato niente!”. Queste ed altre sentenze più taglienti, vengono espresse senza un aspetto scientifico e con inevitabili danni sui pargoli in crescita.
Per rispondere e far chiarezza è opportuno consultare la letteratura scientifica in merito. La psicologia dello sviluppo afferma che le funzioni esecutive (quelle deputate ad organizzare, pianificare, controllare i comportamenti e risolvere problemi) si sviluppano lentamente. Esse maturano tra i 12 e i 14 anni. Questo significa che un bambino o una bambina che frequenta la scuola primaria, non è in grado gestire da solo il processo dei compiti e pretendere che lo faccia genera stress e frustrazione. Quando il bambino è lasciato solo in questa difficoltà, infatti, il suo cervello si attiva in modalità sopravvivenza anziché apprendimento: aumenta l’ansia. Cala la motivazione e si attivano risposte di difesa: “Mi scoccio”, “non lo so fare!”. La mente non è libera di concentrarsi, ma impegnata a salvarsi e difendersi dagli attacchi esterni. Essere accanto non significa sostituirsi (Bertolini, 2001,1989).
L’autonomia come gesto d’amore
L’ autonomia è la capacità di fare da soli. Spesso confusa con l’indipendenza, che è invece è la facoltà di essere chi si sceglie d’essere. Entrambe descrivono una capacità evolutiva, e non un aspetto caratteriale.
L’autonomia si acquisisce da bambini, passo dopo passo. Un ruolo fondamentale è costituito dal legame instaurato con le persone importanti di riferimento, responsabili di accogliere, sostenere e stare accanto. Vygotskij parlava di “zona di sviluppo prossimale”. La Zona di Sviluppo Prossimale (ZSP) è la differenza tra ciò che un bambino può fare da solo (livello di sviluppo attuale) e ciò che può raggiungere con il supporto di un adulto. O di una persona della stessa età, ma più competente (livello di sviluppo potenziale). In questa “zona” si collocano le abilità che il bambino può apprendere con l’assistenza adeguata, ma che non sarebbe in grado di eseguire autonomamente (Bertolini, 2001,1989).
L’autonomia ed il rispetto dei tempi
L’educazione all’autonomia si sviluppa fin da piccoli, attraverso piccoli compiti quotidiani. Sono importanti il coinvolgimento in attività, l’esplorazione dell’ambiente, la fiducia nelle loro capacità e sostenerli negli sbagli. È utile la creazione di un ambiente sicuro e “a misura di bambino”. È fondamentale che gli adulti non si sostituiscano al bambino, ma lo affianchino. Devono permettergli di sbagliare per imparare ad affrontare le difficoltà, favorendo così la crescita della sua autostima e delle sue capacità. L’aspettativa di avere bambini autonomi, tuttavia, non può sopraggiungere prima che ne siano capaci, secondo lo sviluppo psico-emotivo.
L’autonomia come apprendimento dello stare
Una giusta distanza, tra desiderio di essere indispensabili per i propri figli (e di organizzare la loro vita, sostituendosi a loro) e la voglia di vederli subito autonomi è la sfida di ogni genitore. È un processo evolutivo anch’esso che deve declinare le risorse, i bisogni e le capacità acquisite, modulando di volta in volta il comportamento. Essere accanto, non significa sostituirsi al bambino. Essere accanto si traduce in aiutare a capire da dove cominciare. Bisogna sostenerlo nei momenti di blocco (“vedo che sei stanca, facciamo una pausa) e mostrare come organizzarsi (“facciamo una lista insieme”). L’obiettivo non è fare compiti perfetti, ma insegnare a stare insieme nella fatica e nelle difficoltà.
L’autonomia nasce nella relazione di fiducia
L’autonomia è una conquista possibile che nasce all’interno di legame affettivo. Quando un bambino, una bambina, si sente accolto e compreso, trova in sé la motivazione e la calma per fare da solo. Durante i compiti il bambino sperimenta rabbia, paura di sbagliare, noia e frustrazione. L’adulto rappresenta quello specchio calmo per imparare a riconoscerle (educazione affettiva).
Il genitore rappresenta lo spazio sicuro in cui il bambino può esperire le emozioni (ascolto empatico). Può sentirsi accolto anche se sbaglia (accettazione incondizionata) e sperimentare la capacità di crescere (autenticità relazionale). Per lo psicoterapeuta Rogers, la crescita autonoma è la tendenza innata alla realizzazione del proprio potenziale. Questo processo si basa, appunto, sulla fiducia nelle capacità della persona di autodeterminarsi e raggiungere la crescita personale. Supportata da un ambiente di accoglienza incondizionata, empatia e non-giudizio (Rogers, 2013).
Quando accompagniamo i nostri figli con presenza e fiducia, diamo loro la possibilità di sviluppare competenze emotive. Facciamo crescere l’autostima e insegniamo che possono affrontare la fatica senza sentirsi soli (Cavana, 2010). L’autonomia diventa, dunque, una conquista naturale e non, un’imposizione. Sostenere nella fatica i bambini, aiuta altresì a formare l’autoregolazione e la capacità di gestire autonomamente il tempo. Se sento di poter incidere su quello che mi circonda, mi sentirò più libero di agire. Il senso del dovere rivela, infatti, grandi differenze individuali e culturali. Esse in parte risiedono nelle esperienze che le comunità (le famiglie, la scuola, i compagni), fanno sui diversi modi di intendere l’autonomia e l’indipendenza (Mariotti, 2006).
Conclusioni
“L’unica persona che si può ritenere istruita è quella che ha imparato come si fa ad imparare e a cambiare“. Per fare questo, un bambino deve vivere in una relazione affettiva con un genitore che gli infonda fiducia e non si sostituisca a lui.
L’indipendenza, ovvero la capacità di non dipendere da un altro in maniera passiva è un modo utile e libero ad orientarsi nel mondo. Ma altrettanto importante è non crescere e educare i più piccoli con l’idea che si possa fare a meno degli altri, durante l’arco della nostra vita.
Alba Cervone
Bibliografia
- Bertolini, P. (2001), Pedagogia fenomenologica, genesi, sviluppi, orizzonti, La Nuova Italia, Firenze
- Bertolini, P. (Ed.) (1989), Autonomia e dipendenza nel processo formativo, La Nuova Italia, Firenze
- Cavana, L. (2010), Adultità e crisi dell’autorevolezza tra continuità e cambiamento, in “Ricerche di Pedagogia e Didattica”, 5 (1), 1-25
- Latella, R., Funaro, S. & Braccini, A. (2010), Una grammatica del linguaggio educativo. Mappe concettuali per pensare l’agire quotidiano, in: “Animazione Sociale”, 240, 44-56
- Maggiolini, A. (2006), Il conflitto tra genitori e figli adolescenti, in: “Adultità”, 26, 111-122
- Mariotti, G. (2006), Crescere senza conflitti, in: “Adultità”, 26, 22-27
- Rogers C. (2013), La terapia centrata sul cliente, Giunti Ed.
Foto: Envato Elements