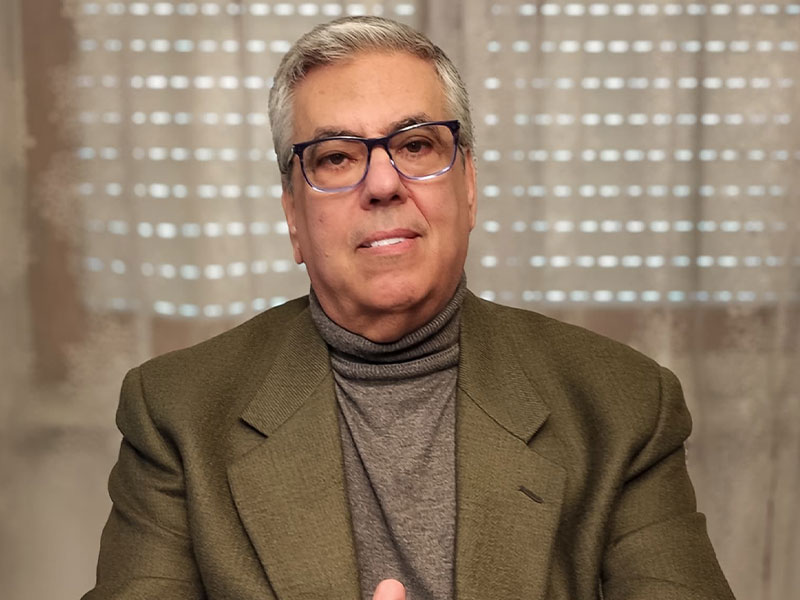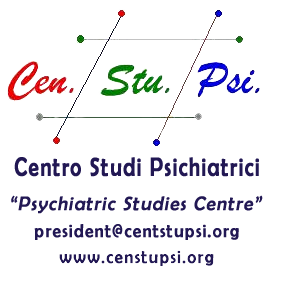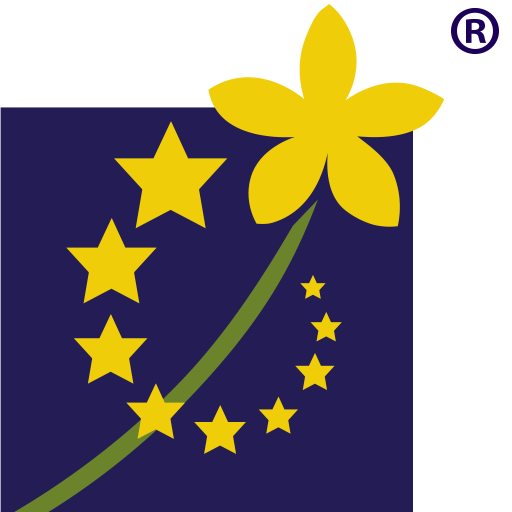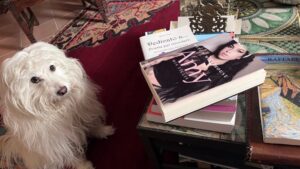Introduzione
La filosofia occidentale, fin dalle sue origini, ha cercato di definire l’essenza dell’uomo, come soggetto cosciente e consapevole. Un passo fondamentale in questo cammino è rappresentato dalla celebre affermazione “Cogito, ergo sum” (Penso, dunque sono) di René Descartes. Questi ha considerato l’individuo come fondamento del sapere. Tuttavia, la comprensione della psiche umana non si è fermata alla filosofia ma con l’avvento della psichiatria, ha aperto nuovi orizzonti alla comprensione del disagio mentale. In questo articolo, accennerò all’evoluzione del pensiero da Socrate a Descartes, per arrivare alla concezione moderna del disagio mentale.
Il pensiero di Socrate e il disagio mentale
Nel mondo antico, Socrate (469-399 a.C.) rappresenta una delle figure fondamentali della filosofia occidentale. La sua ricerca non era tanto rivolta alla formulazione di teorie astratte, quanto alla ricerca della verità interiore, partendo dal principio dell’auto-conoscenza. Il celebre motto “Conosci te stesso”, inscritto nel tempio di Apollo a Delfi, era il fulcro del suo pensiero.
Socrate credeva che il bene e la felicità derivassero dalla conoscenza di sé e che l’uomo dovesse riflettere costantemente sulla propria vita. Il concetto di disagio mentale nel pensiero socratico era sostanzialmente estraneo a quello che oggi intendiamo con questo termine. Il malessere derivante da un disturbo mentale veniva visto come una disarmonia tra l’anima e la ragione. Se l’individuo non riuscisse a riflettere su sé stesso per raggiungere una visione chiara della propria esistenza, questo stato d’animo sarebbe definito, oggi, come un disagio psicologico.
Il “Cogito, ergo sum” di Cartesio, la certezza dell’esistenza e il disagio mentale
Il celebre “Cogito ergo sum” di René Descartes, o Cartesio, rappresenta una pietra miliare nella storia della filosofia. Questo principio, che significa “Penso, dunque sono”, è stato formulato da Cartesio nelle sue “Meditazioni metafisiche” (1641). In realtà in latino Cartesio scrive “Ego cogito, ergo sum, sive existo “, che, tradotto dal latino, suona come: “Io penso, dunque sono, ossia esisto”.
René Descartes (1596-1650) con la sua affermazione “Cogito, ergo sum” segnò una svolta nella filosofia, separando la mente dal corpo. L’individuo era il punto di partenza per la conoscenza. Descartes, attraverso il metodo del dubbio sistematico, arrivò alla certezza che il fatto di dubitare implicava l’esistenza di un pensatore, e quindi l’esistenza stessa. Questo pensiero rappresenta il fondamento della filosofia moderna, dove la coscienza di sé diventa il centro del sapere.
Nella visione cartesiana, la mente è separata dal corpo e la salute mentale è strettamente legata alla razionalità dell’individuo. Il disagio mentale, da un punto di vista cartesiano, sarebbe la manifestazione di una distorsione della ragione. Se la mente fosse in uno stato di equilibrio e chiarezza, l’individuo non avrebbe problemi di natura psichica. Il disagio mentale, pertanto, potrebbe essere interpretato come una perdita della capacità di pensare razionalmente.

Il Cogito e la nascita del soggetto moderno tra dubbio e angoscia
Il Cogito non è solo un’affermazione che si concentra sulla manifestazione filosofica dell’esistenza, ma è alla base dei fondamenti scientifici della coscienza. Esso sancisce la possibilità di una conoscenza certa, fondata sull’auto-consapevolezza. Questo primato della soggettività ha profonde implicazioni anche in ambito letterario.
Pensiamo al romanzo psicologico del XIX secolo, dove l’analisi introspettiva dei personaggi diviene elemento cardine della narrazione. Autori come Fëdor Dostoevskij, in opere come “Delitto e castigo” e “Memorie dal sottosuolo“, esplorano le profondità dell’animo umano. Con esse mettono in scena tormenti interiori, conflitti morali e stati di alienazione che anticipano alcune delle tematiche centrali della psichiatria moderna. Se il pensiero è fondamento dell’essere, cosa accade quando il pensiero stesso è turbato, offuscato dal dubbio o dall’angoscia?
La letteratura esistenzialista del XX secolo, con autori come Jean-Paul Sartre e Albert Camus, mette in luce la fragilità del Cogito. Essa evidenzia la precarietà dell’esistenza e il senso di assurdo che può derivare all’essere umano dalla consapevolezza della propria mortalità. In opere come “La nausea” di Sartre, il protagonista Roquentin sperimenta un profondo senso di disgusto per l’esistenza, una sorta di malattia metafisica che lo isola dal mondo. Questo senso di estraneità e di alienazione anticipa alcune delle manifestazioni cliniche della depressione e di altri disturbi psichici.
La letteratura moderna e il disagio mentale
La letteratura, con la sua capacità di esplorare le profondità dell’animo umano, può offrire un contributo prezioso alla comprensione del disagio mentale. Le opere letterarie ci permettono di entrare in contatto con le esperienze interiori dei personaggi, di comprenderne le sofferenze e le fragilità. Questo approccio empatico può arricchire la prospettiva clinica, offrendo una visione più umana e complessa del disagio mentale. Il tema del dubbio e della ricerca della verità interiore è stato esplorato da molti autori. Ad esempio, in “La coscienza di Zeno” (1923) di Italo Svevo, il protagonista Zeno Cosini con la scrittura analizza le proprie angosce.
Svevo, influenzato dalle teorie psicoanalitiche di Sigmund Freüd, mostra come la riflessione su sé stessi possa portare a una maggiore consapevolezza e, eventualmente, alla guarigione. Un altro esempio significativo è “L’uomo senza qualità” (1930-1943) di Robert Musil, dove il protagonista Ulrich vive in uno stato di costante dubbio e introspezione. Musil esplora la complessità della mente umana e la difficoltà di trovare un senso di identità stabile in un mondo in rapido cambiamento.
Dalla coscienza alla diagnosi. Uno sguardo alla psichiatria
Il percorso dal Cogito alla diagnosi del disagio mentale non è lineare, ma complesso e articolato. Se il pensiero è il fondamento dell’essere, allora le alterazioni del pensiero possono essere considerate come manifestazioni di una sofferenza interiore. A partire dal XIX secolo Philippe Pinel, introduce il concetto di liberazione dei malati mentali dalle catene fisiche e morali. Egli inizia a considerare il disagio mentale come un disturbo che richiede una diagnosi e un trattamento specifico. La psichiatria ha cominciato a classificare i disturbi mentali in categorie precise, basandosi su osservazioni cliniche e, più tardi, su criteri diagnostici definiti come il DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali).
Tuttavia, la riduzione del disagio mentale a una mera categoria diagnostica rischia di appiattire la complessità dell’esperienza umana. Come sottolineato da alcuni studiosi, la diagnosi psichiatrica può diventare un destino, etichettando l’individuo e limitandone la possibilità di esprimere la propria individualità. L’introduzione di tecniche terapeutiche, come la psicoterapia e la farmacoterapia, ha dato nuovi strumenti per trattare il disagio mentale.
Nel contesto attuale, i disturbi mentali vengono studiati attraverso approcci multidisciplinari che comprendono la biologia, la psicologia e la sociologia.
Considerazioni
Dalle riflessioni socratiche passando per la razionalità cartesiana, fino alla diagnostica moderna del disagio mentale, il percorso della filosofia e della scienza ha cercato di comprendere la complessità dell’essere umano. Oggi, sebbene la diagnosi dei disturbi mentali sia basata su criteri scientifici e clinici, il tema del “conosci te stesso” di Socrate e del “cogito ergo sum” di Cartesio, rimane centrale anche nel trattamento e nella comprensione del disagio mentale.
In un’epoca in cui la consapevolezza del disagio mentale è crescente, è essenziale un approccio integrato che consideri sia le scoperte scientifiche quanto la dimensione esistenziale e filosofica dell’individuo. La diagnosi del disagio mentale non deve solo essere una questione di etichetta ma un’opportunità per approfondire la conoscenza dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature, integrando mente, corpo e spirito.
Antonio La Daga
Bibliografia
- Bulletin Cartésien Centro Interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento dal 2007 e in Archives de Philosophie.
- Dostoevskij F Memorie del sottosuolo – Ed. Einaudi, 2014
- Dostoevskij F Delitto e castigo – Ed. Sotto la Quercia, (a cura di), Marco Rispoli, 2024
- Musil R. L’uomo senza qualità. Ed. Mondadori, 2021
- Pinel P. Liberazione e nuovo assoggettamento. Analisi della pratica medica negli hospices des aliéné Novaro Celeste 2023/2024.
- Reale G, Socrate. Alla scoperta della sapienza umana, Milano, Rizzoli, 2001, ISBN 8817126772.
- Cerqueiro D, Psellos M. La Escuela de Atenas y el sentido de “conócete a ti mismo”. Buenos Aires, 2011. ISBN 978-987-9239-21-6.
- Sebba G, Bibliographia Cartesiana. A Critical Guide to the Descartes Literature, 1800-1960, The Hague, Martinus Nijhoff, 1964.
- Svevo I. La coscienza di Zeno -. Ed. Mondadori, 2016
- Sartre JP. La Nausea –Ed. Mondadori, 1964
Foto: Envato Elements