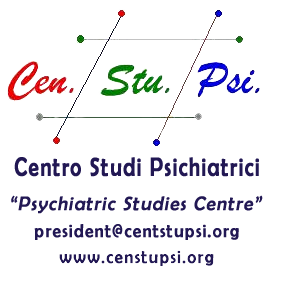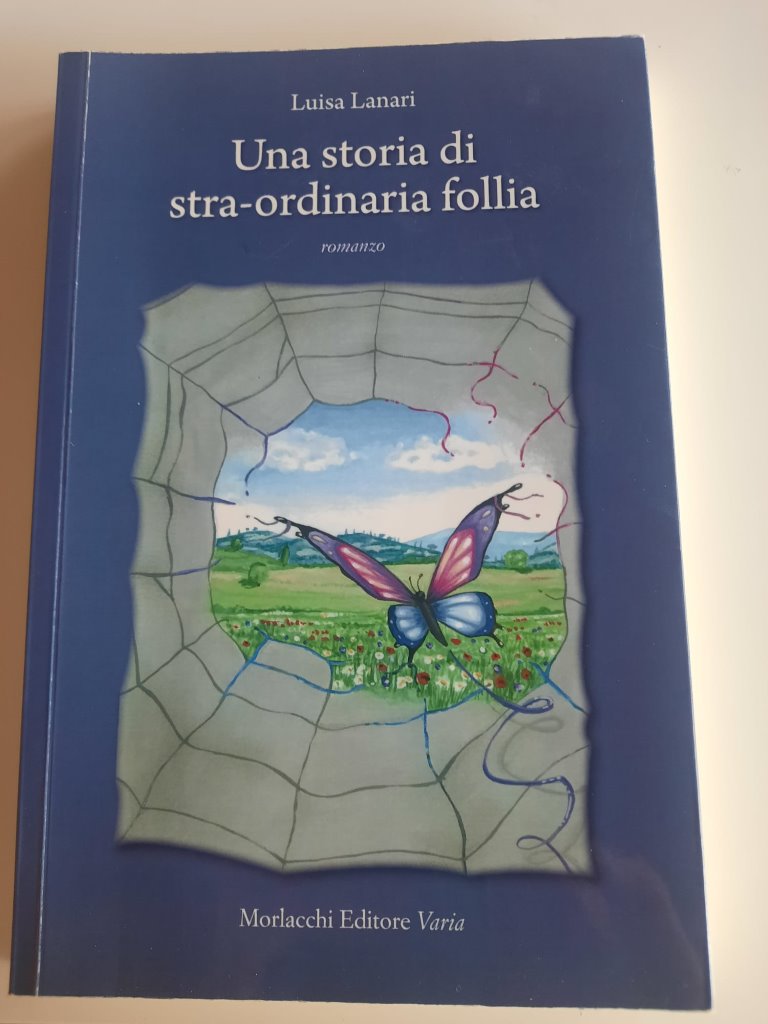Alcuni grandi uomini della letteratura latina come Lucrezio, Cicerone, Orazio, Seneca, e specialmente Ovidio, descrissero con molta chiarezza le sofferenze psichiche e la volontà di suicidio.
Ovidio fu il poeta che, senza reticenze e con clinica descrizione, evidenziò la sua buia depressione negli anni del forzato esilio sulle coste del Mar Nero. Descrisse la sua sofferenza psicofisica: «La mia mente non sta meglio del mio corpo, l’una e l’altro sono malati e io sopporto una doppia infermità». L’anxietas animi (l’angoscia) non lo abbandonava (quae mihi sempre adest), la noia (taedium vitae) e l’insofferenza alla vita gli procuravano desideri di morte (amor mortis). Si sentiva vuoto dentro come un morto che cammina e nonostante ciò riuscì a dare con la sua arte una sofisticata autoanalisi di sé stesso. Egli trovò nella scrittura un valido sostegno terapeutico e necessità di vita. «Se vivo, e resisto … devo ringraziare te, o musa. Tu mi dai sollievo … tu vieni a me come una medicina» (Puliga, 2017).
Il suicidio e il Diritto romano
Nella tradizione dell’antica Roma il suicidio era considerato un diritto di ogni cittadino. Non era considerato un reato ed il fallire il proprio suicidio non comportava il dover rispondere alla legge. La vita era valutata un bene supremo, legato al diritto privato di ogni persona che, pertanto, ne poteva disporre come voleva. Diversamente, chi tentava il suicidio per evitare il servizio militare era punito e congedato con disonore (Comerci, 1830). Il diritto romano interveniva quando sorgevano conflitti tra le persone ed esse chiedevano giustizia. Pertanto il suicidio essendo considerato una libertà personale non era proibito (Manfredini, 2008).
In età imperiale i legislatori romani lo definirono una libertà naturale e ne elencarono i motivi che potevano giustificare l’atto. Le sofferenze fisiche e psichiche, il disgusto per la vita, in caso di follia o per ostentare il disprezzo per la morte, o per lutti e malattia. Tra le varie considerazioni vi era anche la morte opportuna, per cui invece di attendere il suo avvento, si decideva liberamente di anticiparla suicidandosi.
Il suicidio per gli schiavi
La libertà di suicidarsi però era un diritto privato degli uomini liberi, non degli schiavi. Lo schiavo era di proprietà di chi lo acquistava e la sua morte per suicidio era un danno per il suo padrone. Lo schiavo che si procurava la morte era un “cattivo servo”, non in senso morale, ma in quello di perdita possesso per il padrone. Chi vendeva uno schiavo che aveva tentato il suicidio e non lo denunciava al momento dell’acquisto era punibile con il risarcimento al compratore. La vendita era considerata fraudolenta in quanto lo schiavo era “cattivo e difettoso”, al pari di un utensile mal funzionante (Giulio Paolo).
Il suicidio per Seneca
Seneca, filosofo morto nel 65 d.C., riteneva che lo stoico saggio doveva mantenere il suo atteggiamento razionale sia nella vita, sia affrontando la morte. La virtù del sapiente consisteva nel mantenere ferma la propria razionalità in qualsiasi evenienza, anche scegliendo la morte. È necessario un comportamento coraggioso e coerente tale che “sono io a non fuggire la morte”, ma nemmeno che “sarà la vita a sfuggirmi” (Lett., 49.10).
L’uomo è saggio quando manifesta la propria ragione e il suicidio può essere immaginato solo se inteso razionalmente. Se il sapiente dovesse essere minacciato dal rischio di perdere il controllo e di impazzire ha la possibilità di sottrarsi a questa perdita salvando la propria razionalità. Soltanto il saggio sa quando è giunto il momento di scegliere il suicidio, convinto che “morire bene significhi sfuggire al pericolo di vivere male” (Lett., 70.6), (Maso, 2007).
O ancora per salvare la propria onorabilità, come quando Seneca fu condannato a morte da Cicerone per la sua sospetta partecipazione alla congiura di Pisone. L’imperatore romano gli aveva concesso l’onorevole morte per suicidio o l’uccisione come un comune plebeo (Wikipedia). Lo stoicismo romano può accettare il suicidio purché sia una scelta razionale e voluta, non un cedimento alle passioni e l’abbandono alla disperazione.
Morte per devozione
Il suicidio per devozione (devotio), presso gli antichi Romani, era un’originale modo di togliersi la vita. Il comandante di un esercito, nel corso della battaglia poteva sacrificare la sua vita come offerta agli dei Mani, divinità dell’oltretomba e benevoli anime defunte. Lo scopo era quello di ottenere in cambio del suo sacrificio la salvezza e la vittoria dei suoi uomini.
Il suicidio e la confisca dei beni
Dal I al III secolo d.C. alcuni atti giuridici (Digesta), nei condannati a morte per reati gravi era prevista anche la confisca dei loro beni. Però se il condannato prima della sentenza si suicidava poteva evitarne la loro confisca, con il beneficio degli eredi. Successivamente questa norma fu annullata, tranne nel caso che gli eredi testamentari riuscissero a dimostrare il suicidio per grave malattia o taedium vitae del familiare. Nel primo caso era necessaria la testimonianza del medico che ne attestasse le gravi condizioni di salute del suo paziente. Nel secondo caso era lo stesso medico che provvedeva ad intervenire per dare sollievo alla noia di vivere del cliente (Wikipedia).
La morte auto procurata, l’etica e la religione
Dal IV seco d.C. in poi il suicidio venne aspramente criticato, pur non essendo cambiata la legislazione in merito. Sotto l’influsso delle idee neoplatoniche e le predicazioni cristiane di Sant’Ambrogio, Eusebio di Cesarea, S. Agostino cambia la considerazione del suicidio tra gli antichi romani. Passa da un comportamento accettato, giustificato e lecito ad una aperta condanna morale e religiosa.
Considerazioni
Gli antichi giuristi romani aderirono alla massima degli stoici che legittimavano il suicidio quale massima espressione di una libera volontà razionale e logica. Però non doveva portare danno ad altri e lo punivano, come nel caso dello schiavo “difettoso”. Né doveva essere una modalità di tutela per i propri eredi con danno al fisco per la mancata confisca dei beni dei condannati a morte. E pur cambiando la sua considerazione, ai tempi del cristianesimo, il suicidio non era considerato un atto illecito anche se peccaminoso e non etico.
Maurilio Tavormina
Bibliografia
- Comerci Nicola (1830) Lo studio del diritto romano. Le Instituta e le Pandette Per lo Regno delle Due Sicilie. Versione italiana. Volume 1. [-3.] – Napoli: stabilimento letterario tipografico dell’Ateneo,1830, p.391.
- Manfredini A D (2008) Il suicidio. Studi di diritto romano, G. Giappichelli, 2008.
- Puliga Antonella (2017) La depressione è una dea. I romani e il male oscuro. Il Mulino, 2017.
- Sant’Agostino di Ipponia, De Civitate Dei. Nuova Città Editrice, libro I, pag. 20, 1974.
Sitografia
- Giulio Paolo, Dig XXI,1,43, 4 Giulio Paolo – Wikipedia
- Maso Stefano, (2007) Seneca e le riflessioni sulla morte Seneca e la riflessione sulla morte – Treccani Portale (archive.org)
- Wikipedia il suicidio nell’antica Roma Suicidio nell’antica Roma – Wikipedia
Foto: Wikipedia -M.D. Sánchez, “Il suicidio di Seneca”, 1871, Museo Naz. Prado -Madrid