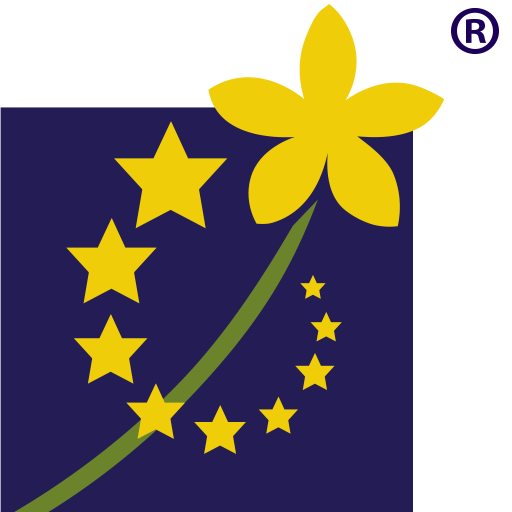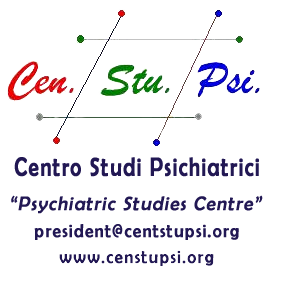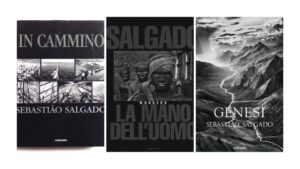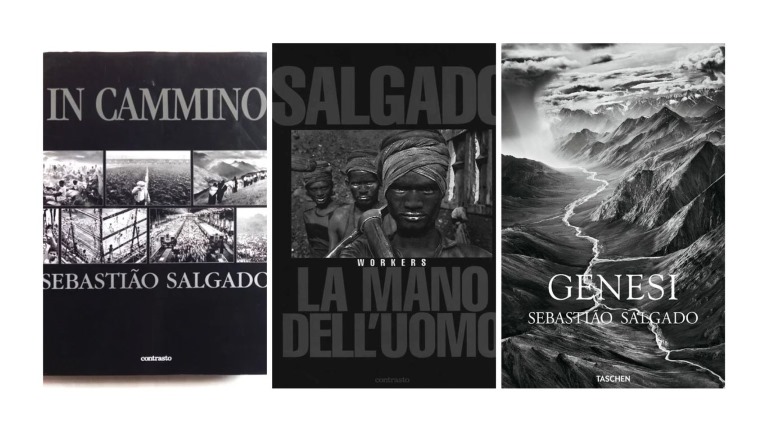Introduzione
La depressione dell’umore si presenta già agli albori della civiltà con lo scoraggiamento, la tristezza, la malinconia. È presente l’apatia, il taedium vitae e l’incapacità di reagire positivamente alle avversità della vita. Si può dire che la depressione nasca con l’uomo. Molte culture antiche riportano cambiamenti dello stato d’animo e del comportamento delle persone che oggi potrebbero essere diagnosticati come una patologia depressiva. Omero nell’Iliade descrive con molta cura la malinconia di Bellerofonte, la profonda angoscia e la sua disperazione.
“[…] ma quando viene in odio agli Dei, Bellerofonte solo e consunto di tristezza errava pel campo acheo l’infelice e l’orme dei viventi fuggìa […]” (Omero).
Con l’abbandono della benevolenza degli dei l’antico eroe greco perde il coraggio, la forza di combattere e di vivere. Vaga per i campi affranto, sconsolato e si isola dal contatto umano con un vuoto interiore assoluto e una tristezza devastante. Questa immagine dell’eroe caduto, emarginato e incompreso, rappresenta uno dei ritratti più umani e struggenti della mitologia greca (Graves, 1955)
In questo articolo metto in risalto non solo le imprese di Bellerofonte, ma anche la sua profonda malinconia e depressione, così come può essere intesa nei tempi moderni.
Le origini di Bellerofonte
Bellerofonte è una figura affascinante, di bell’aspetto e complessa. Secondo la tradizione mitologica era figlio del re di Corinto e di Eurimede e discendente della stirpe di Sisifo (Apollodoro, II). Questo antico eroe greco ha vissuto una vita avventurosa e tragica, ricca di successi, ma anche di grandi sofferenze. Fin dalle sue origini l’eroe è segnato da un evento tragico e da un senso di colpa che lo accompagnerà per tutta la vita. Questo dettaglio conferisce alla sua figura una profonda vena malinconica, che lo distingue da altri eroi mossi da pura sete di gloria e di potere.
Il mito di Bellerofonte
Bellerofonte uccise involontariamente suo fratello Bellero e pertanto fuggì alla corte del re Preto, ad Argo. La moglie di quest’ultimo si innamorò di lui e non assecondata nel suo amore, accusò Bellerofonte presso Preto di cattive intenzioni e violenza alla sua persona. Il re, obbedendo alla Xenia (l’ospitalità sacra dei Greci) non si vendicò e lo mandò con una lettera al padre di sua moglie, Giobate, re di Licia. Gli chiese di giustiziare Bellerofonte. Giobate si rifiutò di ucciderlo, perché suo ospite, ma lo espose ai pericoli di un’impresa impossibile e di cui avrebbe potuto essere vittima. Gli chiese di uccidere la terribile Chimera, delegando così le sorti dell’ospite al volere degli dei.

“La Chimera di Arezzo”, statua etrusca in bronzo, c. 400 a.C. Museo Archeologico Nazionale, Firenze.
Le divinità furono benevole per la sua innocenza e gli inviarono il cavallo alato Pegaso. Con il suo aiuto uccise la Chimera, un mostro dal corpo di leone, con la coda di serpente e sul dorso aveva la testa di una capra fiammeggiante. Vinse e sottomise il crudele popolo dei Solimi, brutali guerrieri che abitavano l’Asia Minore, e le forti e valorose Amazzoni.
Giobate ne fu così preso che si scusò con l’eroe, diede a Bellerofonte sua figlia Filonoe in moglie e lo nominò suo successore. La fine del valoroso non fu così felice come la sua vita. Le divinità, per invidia, cominciarono a odiarlo per la sua arroganza e lo fecero cadere dal cavallo alato Pegaso. Bellerofonte zoppo, vagava solitario e triste, con grande angoscia nel cuore e fuggiva i sentieri degli uomini.
La moglie Filonoe gli diede tre figli: Isandro, Ippoloco e una figlia Laodamia. Marte uccise Isandro in battaglia, la dea Diana gli rubò la figlia, ma Ippoloco ereditò il regno di suo padre (sito 1).
Il simbolo della fragilità umana e la punizione divina
La storia di Bellerofonte rappresenta un esempio perfetto della visione greca della condizione umana. Eroi come lui sono figure di confine che hanno la capacità di compiere imprese straordinarie. Ma inevitabilmente sono destinati a confrontarsi con la propria mortalità e con la volontà divina.
La depressione di Bellerofonte emerge chiaramente nella seconda parte della sua vita. Dopo aver raggiunto grandi traguardi, l’eroe si trova improvvisamente solo e incompreso. Il desiderio di raggiungere gli dèi dell’Olimpo, spinto dall’arroganza e dalla disperazione, lo porta a tentare un’impresa impossibile.
Bellerofonte, accecato dalla forza delle sue imprese e credendo di essere meritevole dello status di divinità, tenta una folle scalata all’Olimpo in groppa a Pegaso. Ma gli dèi non possono tollerare il suo desiderio di oltrepassare i limiti imposti alla conoscenza umana. Il superbo eroe fu punito da Zeus con la rovinosa caduta dal cavallo alato.
La fine di Bellerofonte viene presentata come l’inevitabile conseguenza di un atto di hybris (arroganza), colpa tipicamente degli eroi e di chi superbamente crede in sé. La sua storia, tramandata da autori come Omero, Pindaro ed Euripide, rimane ancora oggi un simbolo della fragilità umana.
Paragone con altre figure mitologiche
Un confronto interessante si può fare con la figura di Icaro, un altro eroe della mitologia greca che, come Bellerofonte, cercò di superare i limiti umani. Icaro volò troppo vicino al sole con ali di cera e piume, che si sciolsero facendolo cadere in mare. Entrambi gli eroi condividono una sorte tragica, causata dal loro desiderio di oltrepassare i confini imposti dagli dèi (Ovidio, Metamorfosi, Libro VIII).
La malinconia di Bellerofonte
Il tema della melancolia viene affrontato nel primo capitolo del Problema XXX.1. Un testo di scuola aristotelica attribuito allo stesso Aristotele, in cui Bellerofonte viene citato, insieme ad Aiace ed Eracle, come eroe afflitto da umor nero. La melancolia intesa come patologia e aspetto caratteriale è suscettibile, secondo l’autore, di provocare prestazioni fuori dal comune in vari ambiti del sapere. Si associa così il genio alla sofferenza e alla follia.
In Bellerofonte l’inizio della malinconia compare con la morte dei figli e invalida la certezza del protagonista di essere benvoluto dagli dèi. Nel testo di Preller (1861), la versione di Euripide del mito di Bellerofonte presentava la scomparsa dei figli come importante elemento nello sviluppo tragico della vicenda.
Riflessioni
La depressione di Bellerofonte potrebbe essere messa in relazione oltre alla morte dei figli, anche l’esaurimento della forza dello spirito eroico dell’uomo, logorato dallo scorrere del tempo. Una forma di moderno burnout per le profuse e stressanti imprese eroiche. Ma è anche un potente monito sui pericoli dell’arroganza e della solitudine dell’uomo che sfida gli dei, la natura e l’ordine costituito delle cose.
La sua vita, segnata da grandi successi e profonde sofferenze, ci ricorda la fragilità umana e i limiti dei mortali. La figura di Bellerofonte rimane un simbolo eterno della lotta tra l’ambizione e la caducità della vita.
Maurilio Tavormina
Bibliografia
- Apollodoro, Biblioteca, traduzione di James George Frazer, Harvard University Press, 1921.
- Aristotele (2018), Problema XXX, 1. Perché tutti gli uomini straordinari sono melancolici, a cura di Centrone B., Pisa, ETS.
- Graves R, The Greek Myths, Penguin Books, 1955.
- Omero, Iliade, Libro VI, versi 155-202, traduzione di Richmond Lattimore, University of Chicago Press, 1951.
- Ovidio, Metamorfosi, traduzione di A.D. Melville, Oxford University Press, 1986.
- Preller L (1861), Griechische Mythologie. Zweiter Band. Die Heroen, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung
Sitografia
- McClintock e Strong Biblical Cyclopedia: https://www.biblicalcyclopedia.com/B/bellerophon-(or-bellerophontes).html
- Braccini M. Ascesa e caduta di un eroe: Bellerofonte – https://inerba.fileli.unipi.it/articoli/inerba-3-2022-2023-braccini/
Foto: Envato Elements
Foto: “La Chimera di Arezzo”, statua etrusca in bronzo, c. 400 a.C. Museo Archeologico Nazionale, Firenze. Wikipedia immagini, GNU Free Documentation License