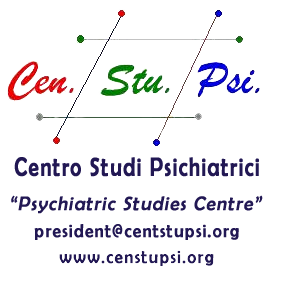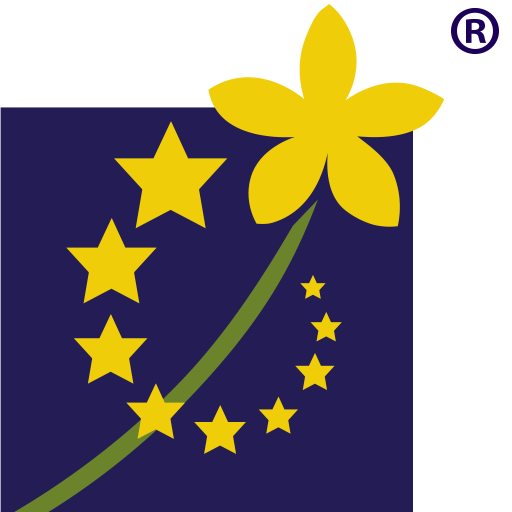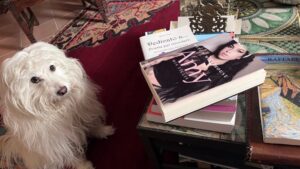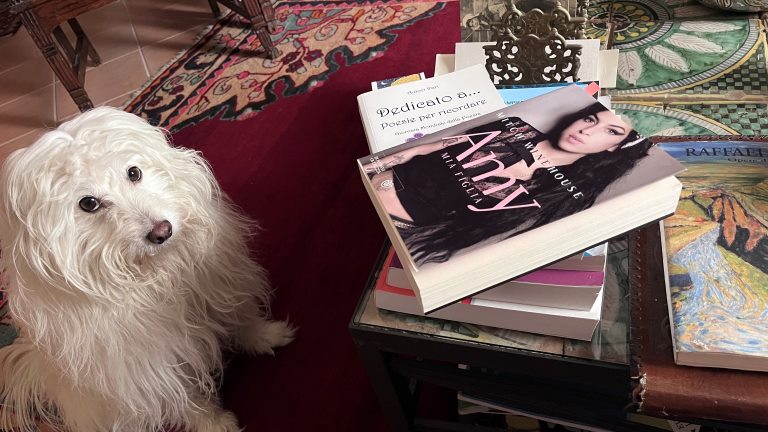Introduzione
C’è una parola che oggi mette a disagio: la lentezza. Sembra una colpa, una malattia da curare con le vitamine dell’efficienza. Viviamo nel culto del “subito”: messaggi istantanei, emozioni istantanee, fotografie istantanee. Tutto deve essere prontissimo: cotto e mangiato, anzi prima mangiato e poi cotto. Se rallentiamo, non stiamo sbagliando: stiamo osservando. La fotografia lenta ci aiuta ad immortalare il soggetto, aspettando il momento giusto.
Andare lenti non significa essere pigri, ma allenare lo sguardo. La lentezza non è inerzia, ma una forma di concentrazione attiva. È un muscolo da esercitare per non essere travolti dal rumore di fondo e dal caos. Chi va lento non rinuncia alla meta: la prepara, la scolpisce con pazienza. È come imparare a respirare sott’acqua: serve pratica, ma poi scopri che anche lì c’è ossigeno. Il presente esiste solo se lo abitiamo con attenzione ci suggeriscono tutti i lavori fotografici degli artisti citati in questo articolo.
La fotografia lenta come movimento artistico culturale
Il movimento della fotografia lenta si distingue per un approccio meditativo e riflessivo. Fotografare lentamente significa scegliere con cura, aspettare il momento giusto, immergersi nel soggetto e permettere che la fotografia emerga da una relazione autentica. Spesso si ricorre a tecniche analogiche non più in voga con la fotografia digitale, oppure si usa la tecnica delle lunghe esposizioni.

Osservare il presente con la fotografia lenta
La lentezza oggi è un atto di resistenza. Fermarsi a osservare, respirare, prendere tempo: tutto ciò sembra rivoluzionario in un mondo che corre. Ma andare lenti non significa essere privi di energia o motivazione; significa allenarsi a osservare e vivere il presente. Il presente è il luogo in cui possiamo scegliere, il momento in cui possiamo ricucire un legame con quella parte di noi che pensiamo sia distante.
Andare lenti significa imparare a vedere davvero, senza fretta. Ogni dettaglio, ogni sfumatura diventa un’occasione per esercitare attenzione. La lentezza permette di riappropriarsi del tempo interiore e di trasformare il vedere le cose passivamente nel guardare con attenzione e consapevolezza. Fotografare lentamente significa riconoscere la luce, le ombre, il movimento minimo che sfugge allo sguardo distratto. Nel cercare un punto di ripresa migliore o più consono al gusto estetico di chi riprende. Andare lenti significa imparare a vedere davvero. È un esercizio a togliere il superfluo.
Alex Noriega (opere dal 2010 al 2025) cattura paesaggi con lunghe esposizioni fotografiche e attenzione alla luce naturale. Ci invita a soffermarsi sulla delicatezza dei momenti: paesaggi intimi e meditativi.
Michael Kenna dal 1980 fotografa paesaggi minimalisti in bianco e nero, lunghe esposizioni che catturano il tempo silenzioso.
Hiroshi Sugimoto comincia nel 1978 a fotografare teatri, mari ed eventi climatici in bianco e nero, dove l’attesa diventa immagine.
Allenare la curiosità con la fotografia lenta
La curiosità va coltivata e la lentezza offre lo spazio per farlo. La fotografia lenta permette di chiedersi, osservare, sperimentare, confrontare. La lentezza educa a essere spettatori attivi, capaci di cogliere dettagli che altrimenti sfuggirebbero e di essere anche critici e capaci di fare confronti. La curiosità non è spontanea se siamo sempre distratti: va allenata. Nella fotografia lenta, come nelle esperienze quotidiane, impariamo a non accontentarci del superficiale. La lentezza ci educa a saper cogliere le differenze. Tutto ciò è palestra non solo per la visione e l’estetica, ma anche per i neuroni.
Luigi Ghirri (1969-1985) viene considerato internazionalmente un maestro della lentezza e dell’osservazione poetica del quotidiano. Nelle sue immagini minime (case, finestre, segnali stradali) si esercita lo sguardo curioso e riflessivo. Una sua citazione: “Guardare è già un atto creativo, non esiste sguardo innocente”. È perfetta per sintetizzare l’idea di curiosità come allenamento percettivo.
Rinko Kawauchi fotografa dal 1998 composizioni delicate che invitano a soffermarsi su gesti e oggetti minimi della vita quotidiana. È la meraviglia dell’ordinario: una mano, una bolla, la luce sul tavolo. La sua fotografia unisce la lentezza allo stupore della riscoperta continua di ciò che è sotto i nostri occhi. La curiosità come forma di attenzione gentile al mondo intorno a ciascuno.
Minor White (lavori dal 1946 al 1976) Concepisce la fotografia come esercizio spirituale e strumento di auto consapevolezza. Comincia a fotografare dopo aver fatto il militare nelle Filippine durante la Seconda Guerra Mondiale. Vale citarlo: “Quando fotografi le cose per ciò che sono, non le vedrai mai per ciò che altro sono”. In altre parole: se ci limitiamo a cogliere l’aspetto letterale o immediato del soggetto, perdiamo la possibilità di percepirne la dimensione simbolica, emotiva o interiore. Quella che si rivela solo attraverso uno sguardo lento, curioso e consapevole.
Ritessere alleanze con sé stessi tramite la fotografia lenta
La lentezza è inoltre cura di sé stessi: permette di entrare in contatto con le parti di noi trascurate dal ritmo frenetico. Il presente diventa uno spazio di scelta, un luogo dove dialogare con emozioni, ricordi e desideri, ristabilendo equilibrio tra mente, corpo e mondo esterno.
W. Eugene Smith ci insegna che la lentezza è anche rispetto. Attivo tra gli anni ’30 e la fine dei ’70, fu uno dei maestri del fotoreportage. È capace di trasformare la cronaca in racconto umano. Ogni suo scatto è un atto di empatia, un modo per restituire dignità e profondità all’esperienza delle persone. Nel celebre reportage Country Doctor (1948), dedicato alla vita di un medico in una piccola comunità agricola americana, lo sguardo si fa ascolto. La macchina fotografica diventa strumento di cura.
Con Sally Mann, attiva dagli anni ’80, la lentezza si trasforma in contemplazione. Nei suoi ritratti e nei paesaggi del Sud degli Stati Uniti, la fotografia diventa un dialogo silenzioso tra corpo, memoria e tempo. Ogni immagine è un respiro sospeso, un gesto che riconnette la presenza al sentimento del vivere.
Le fotografie di comunità e paesaggi umani di Josef Koudelka, attivo dagli anni ’60, non raccontano soltanto: partecipano al vissuto ripreso attraverso la pazienza dell’attesa. In esse la lentezza diventa un modo per ricucire lo sguardo al mondo e ritrovare, nel ritmo del reale, la propria interiorità.
Il valore della non utilità e la fotografia lenta
Non tutto ciò che facciamo deve produrre un risultato misurabile. La lentezza ci ricorda che il senso delle cose può risiedere nell’esperienza stessa. La fotografia lenta non cerca il sensazionale, ma lo stupore e la sorpresa per poter entrare in relazione con ciò che osserviamo e trovare bellezza nei dettagli. Inoltre, non tutto ciò che facciamo deve produrre un risultato misurabile. La lentezza ci ricorda che il senso può risiedere nella qualità dell’esperienza visiva.
Alex Webb, attivo dagli anni ’70, è considerato un precursore di quella che oggi si definisce fotografia di strada. Egli mostra come la lentezza possa convivere con il dinamismo urbano. Nei suoi scatti, il colore e la complessità emergono solo attraverso l’attesa, l’ascolto e la disponibilità a lasciarsi sorprendere: è il tempo, ancora una volta, a restituire profondità.
Nei lavori di Eva Polak, attiva dagli anni 2000, la sfocatura diventa poesia del tempo. L’immagine non è più un istante catturato, ma un’esperienza dilatata, dove la pazienza assume valore estetico e meditativo. Movimento e attesa vengono fusi in linguaggio visivo tecnicamente dilatato.
Andare lenti per andare lontano
La lentezza non è inerzia, è energia concentrata. Permette di percorrere distanze più lunghe, capire meglio la strada, trasformare ogni passo in un atto consapevole. La fotografia lenta diventa metafora della vita: chi si prende il tempo per guardare veramente, acuisce il proprio senso del mondo. Andare lenti, in fondo, significa non avere fretta di arrivare: è scegliere di restare nel cammino, dove la visione si allarga e la vita stessa diventa fotografia. Si matura la consapevolezza del viaggiatore.
Mario Giacomelli (1955–2000) ci ha lasciato paesaggi segnati dalla presenza umana, composizioni in cui il bianco e nero diventano linguaggio poetico. Le sue fotografie, nate da pazienza, studio e dedizione, raccontano il legame tra la terra e chi la abita, tra la luce e la memoria.
Edward Weston (1910–1958), infine, ci invita a guardare da vicino. Nei suoi dettagli naturalistici e negli oggetti quotidiani elevati a forme estetiche, la lentezza diventa sguardo contemplativo: ogni immagine è un atto di esplorazione consapevole, un esercizio di presenza.
Conclusioni
L’andare lenti non è un ritorno romantico al passato, ma un gesto politico, terapeutico, estetico. È un modo di dire: “Non tutto ciò che corre va da qualche parte.” C’è più energia in un passo consapevole che in cento metri di fuga. La lentezza non ci toglie potenza, ce la restituisce in forma di presenza.
Allenarsi alla lentezza significa imparare a ricostruire alleanze con il nostro corpo e con i nostri pensieri. Bisogna allearsi con le parti di noi che avevamo lasciato indietro, per stare al passo con qualcosa o qualcuno. È l’arte di convivere con il tempo invece di combatterlo. Chi pratica la lentezza – nella vita come nella fotografia – scopre che il mondo non scappa: siamo noi che, a forza di correre, lo perdevamo di vista. E allora sì: bisogna andare lenti per andare lontano, perché solo chi si ferma un momento riesce davvero a vedere la strada. E la fotografia lenta ci aiuta a vivere meglio l’attimo fuggente della nostra vita.
Luigi Starace
Bibliografia
- Campany, David. Safety in Numbness: Some remarks on the problems of ‘Late Photography’. 2003.
- Svendsen, Johanne Seines. Through a Glass, Darkly. FingerPrint, 2013.
- Noriega, Alex. “Interview with Alex Noriega: What Slow Photography Means to Him.” Slow Photography Movement, 2019. (slowphotographymovement.com)
- Hodgson, Francis. “Slow Photography.” Francis Hodgson Photography, 2023. (francishodgson.com)
- Polak, Eva. Slow Shutter Speed Techniques. Blurb, 2024. (blurb.com)
Foto: “Fotografia lenta” di Luigi Starace, 2025