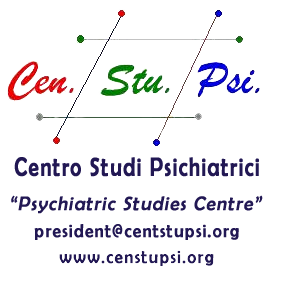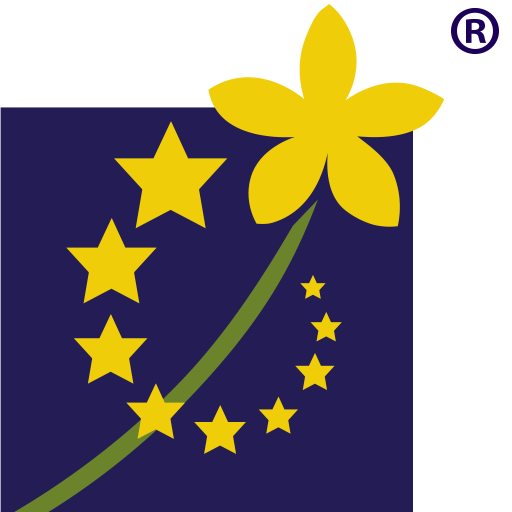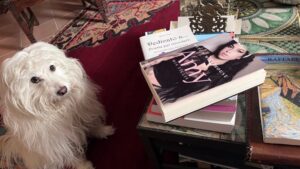Introduzione
In ogni pratica religiosa la penitenza è legata alle pratiche di digiuno e alla redenzione dai peccati terreni, a parte lo Zoroastrismo che lo proibisce. Nel primo cristianesimo il digiuno era un modo di pregare. La sofferenza legata alla deprivazione del piacere del cibo permetteva di liberarsi dal peccato e di rafforzare lo spirito, riconciliandosi con Dio.
Un famoso digiuno, quello del Ramadan, che nel calendario islamico ricorre il nono mese dell’anno, viene considerato un precetto religioso. Consiste nell’astensione dal cibo e dal sesso, dall’alba al tramonto. A differenza dal Cristianesimo, qui il significato del digiuno è diverso. Nel Corano il digiuno viene visto come un atto di lode e ringraziamento, mentre nel cristianesimo come purificazione dal peccato.
Il digiuno e le sante digiunanti
Nell’ambito del Cristianesimo, dal XII secolo in poi alcune figure storiche o religiose, spesso donne, hanno vissuto esperienze di digiuno estremo. La privazione alimentare era parte della loro spiritualità e della ricerca di una connessione più profonda con il divino. Alcune donne sono state venerate come sante, simboli di sacrificio e dedizione: le sante digiunanti. Altre furono oggetto di sospetto da parte della chiesa cattolica che perseguiva le eresie per i comportamenti eccentrici sfidanti le norme sociali (sito1).
Digiunanti come segno di devozione. Le più famose: Santa Vilgeforte, S. Chiara d’Assisi, S. Teresa d’Avila, S. Caterina da Siena. Dacia Maraini considera il rifiuto del cibo come una delle ribellioni di Santa Chiara, «la quale, quando non digiunava, consumava un’oncia di pane al giorno». Il digiuno delle sante nel cattolicissimo Medioevo è stato interpretato come una risposta alla struttura sociale e patriarcale imperante (Maraini, 2013).
Vandereycken e Van Deth hanno attribuito a molti dei casi di sante digiunanti o di padri del deserto il significato antesignano delle moderne forme di anoressia restrittiva. In “Dalle sante ascetiche alle ragazze anoressiche” si possono riscontrare svariati aspetti caratteristici presenti in tale patologia (Vandereycken & van Deth, 1995).
La santa anoressia
Rudolph Bell in La santa anoressia scrive: «[…] mi parve chiaro che alcune sante del tardo medioevo venivano descritte in termini molto prossimi alle descrizioni cliniche dei moderni ammalati di anoressia nervosa». E ancora si chiede «Che cosa potevano avere in comune Twiggy e Karen Carpenter con Chiara d’Assisi e Caterina da Siena?» Consiglio vivamente la lettura di questo libro per chi volesse approfondire questo tema. Nel primo capitolo esamina come l’anoressia nervosa sia stata definita e trattata nel corso dei vari secoli. Tenta di dimostrare come non si tratti di una malattia nuova iniziata con le modelle e con la mania delle diete. Bensì di una patologia che ha un senso e un significato profondo.
Nella prima parte del libro ci parla di Caterina da Siena morta come diretta conseguenza del digiuno estremo e prolungato, complicato infine dalla sua decisione di non bere. Non bevendo dopo un mese morì, disidratata. Raimondo da Capua, il suo confessore, descrive il nuovo stile di vita di Caterina, di all’incirca 27 anni: «[…]il suo stomaco non poteva digerire niente […] per cui quanto aveva ingerito, bisognava che riuscisse per la stessa via per la quale era entrato, altrimenti le causava acutissimi dolori ed enfiature in quasi tutto il corpo. La santa vergine nulla inghiottiva delle erbe o altro che masticava […] beveva volentieri acqua fresca per mitigare l’arsione […]. Questo genere di vita lo tenne fino alla morte che avvenne circa sei anni dopo per causa dei mormoratori e particolarmente di quelli che si scandalizzavano del suo digiuno.»
Successivamente, osserva Bell, il fenomeno dei santi digiunatori andò scemando. L’astinenza dal cibo non venne considerata più la via preferenziale per raggiungere la santità. La devozione a Dio non era più legata alle pratiche ascetiche, ma alla carità e all’assistenza (Bell, 1992).

Il digiuno e l’anoressia nervosa
L’anoressia nervosa sembra essere la patologia del rifiuto. Il rifiuto del cibo. E attraverso esso il rifiuto del corpo. Il rifiuto per demarcarsi, il rifiuto come un appello, come una difesa. Insorge spesso in adolescenza dove già di per sé ci si contrappone; è la fase dei “no”! La contrapposizione dell’adolescente esprime il bisogno di demarcazione e differenziazione. L’adolescente, infatti, viene angosciato non dall’assenza dei genitori ma dalla loro presenza! Il “no” è esigenza di separazione.
Il rifiuto del cibo nell’anoressia nervosa è una esigenza di separazione. È una difesa che permette di sganciarsi dall’Altro e dal Mondo. L’anoressico dice no al cibo perché necessita di differenziarsi dall’Altro e centrarsi su di sé. Il rifiuto è anche un appello. Appello che può prendere anche la forma del ricatto.
Il corpo e l’anoressia
Il corpo viene sequestrato per ricattare l’Altro. E quando l’Altro cede è probabile che la persona che soffre di anoressia riprenda a mangiare. Ma anche no! Dovevi farlo prima! E il ricatto continua. Possono divenire spietati.
Il rifiuto del corpo come luogo dove si esprime il potere. Attraverso l’anoressia si tenta di asservire il corpo alla forza di volontà. Il che vuol dire giudicare il proprio valore principalmente o esclusivamente in base alla forma del corpo, al peso e al controllo. E riporre il valore personale solo sulla base di questo. Possiamo ipotizzare che il corpo rappresenti nei disturbi alimentari un centro di gravità permanente e sia il suo cuore psicopatologico. «Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente» recita la famosa canzone di Franco Battiato.
Quando i rapporti con l’Altro e il Mondo sono difficili e falliscono, quando non si riesce a reggere l’Altro, il ragazzo si ritira. Si centra solo sul corpo tagliando completamente il mondo fuori. Affamandolo. Il corpo diventa l’unico suo interlocutore. In questo modo viene mantenuto un senso di autonomia senza sprofondare in un senso di vuoto. E inizia la battaglia contro un corpo, il proprio, che urla per fame e per stanchezza.
Il corpo che viene usato, pertanto, come contesto fisso e si affranca così dalla definizione dell’Altro. Non avverte più il senso di vuoto, perché un corpo affamato si fa sentire. Il riuscire ad affamare il corpo da valore. Il controllare il senso di fame da valore. Inizia così una indipendenza da tutto, ma che diventa estenuante, una prigione. Il mondo dell’anoressia nervosa si chiude così tra il frigo e la bilancia.
Il digiuno di Caterina
Il “no” di Caterina da Siena inizia in adolescenza. La madre è una donna forte che vorrebbe un matrimonio ricco per Caterina. Il padre è una figura periferica e non supportiva per la figlia. Pertanto, è una figura deludente per Caterina. Anche se infine fu l’unico a darle l’approvazione, intimando alla moglie e ai figli di non tormentarla più. Sembra, pertanto, che la scelta anoressica sia l’unico modo per definirsi e differenziarsi in una società dove il suo destino è segnato. Una ribellione. Una esigenza di separazione.
Caterina nella sua vita fu sempre in lotta per farsi capire oscillando tra illusioni e delusioni. E si centrò su Dio, il che le diede la forza e la costanza di affrontare il mondo e il confronto con i suoi diffamatori. «Rafforzata da un patto personale con Dio, Caterina sortì in battaglia contro la famiglia». Dio solo non la può deludere e abbandonare, così le possibili disconferme vengono evitate. Si centra sul corpo dove unicamente lei ha il potere, con la costante necessità di controllarlo totalmente. Cedere al cibo è come cedere al peccato. È deludere Dio, perdendo il potere faticosamente guadagnato. È annullare il senso di identità conquistato. E Caterina vince tutte le sue battaglie confermando il proprio senso d’identità. Tranne l’ultima, il fallimento della riforma della Chiesa. Qui cedette la voglia di vivere di Caterina (Bell R., 1992) (sito 2).
Considerazioni
Sante e mistiche medioevali hanno vissuto spesso un rapporto complesso con il cibo. Come abbiamo visto sopra alcuni studiosi hanno utilizzato la chiave di lettura dell’anoressia per leggere questo fenomeno. È lecito, quindi, chiederci se siamo di fronte a una modalità tipica medioevale per glorificare Dio o a una patologia psichiatrica! (sito 3).
Queste sante sono vissute in un’epoca storica in cui la relazione con il cibo e il corpo era influenzata da fattori culturali e sociali. Una lente contemporanea può, invece, interpretare queste manifestazioni alla luce della moderna psicopatologia.
Io credo che le manifestazioni del misticismo e della santità non debbano essere ridotte a delle pure categorie psichiatriche. Trovo, però, intrigante cercare di coglierne sensi e significati profondi sottesi, attraverso gli studi fenomenologici. Effettivamente un argomento complesso.
Immacolata d’Errico
Bibliografia
- Bell R.: La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo ad oggi. Oscar Mondadori. 1992.
- Maraini D.: Chiara d’Assisi. Elogio della disobbedienza. Rizzoli ed. 2013.
- Vandereycken W., van Deth R.: Dalle sante ascetiche alle ragazze anoressiche. Il rifiuto del cibo nella storia. Raffaello Cortina ed. 1995
Sitografia
- https://frida.unito.it/480_mangiare-%28da%29-dio%3F-cibo-e-salute-spirituale-tra-medioevo-e-contemporaneit%C3%A0#:~:text=Nelle%20sue%20opere%2C%20Dacia%20Maraini,di%20un%20%E2%80%9Ccorpo%20felice%E2%80%9D.
- https://psicolibra.it/wp-content/uploads/2020/06/Anoressia-e-santit%C3%A0-in-S.pdf
- https://frida.unito.it/480_mangiare-%28da%29-dio%3F-cibo-e-salute-spirituale-tra-medioevo-e-contemporaneit%C3%A0
Foto: Envato Elements