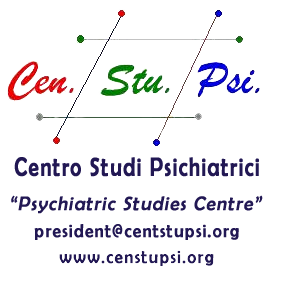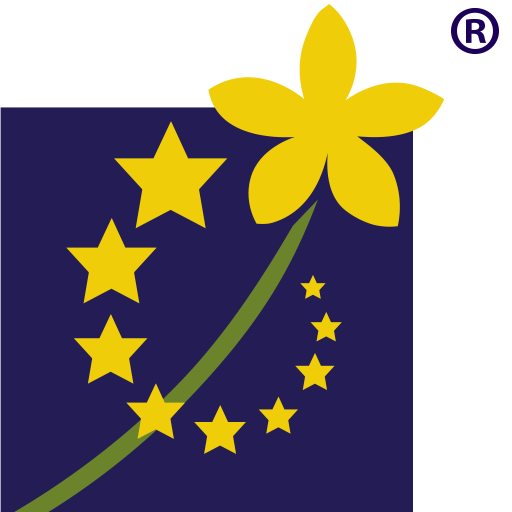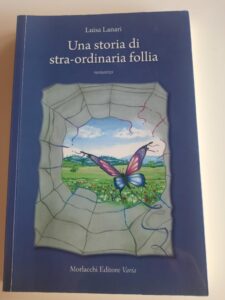Introduzione
L’amigdala è una piccola struttura a forma di mandorla che ha un ruolo fondamentale nel circuito delle emozioni. Il cervello umano ne possiede due e sono localizzate nella profondità degli emisferi cerebrali, destro e sinistro. Essa fa parte di una struttura più complessa definita sistema limbico il cui compito è finalizzato alla regolazione delle emozioni, della memoria, del comportamento e dell’apprendimento. Le altre strutture coinvolte nel circuito emozionale sono il talamo, la neocorteccia e la corteccia prefrontale.
Questo circuito raccoglie e interpreta i segnali che provengono dagli organi di senso come vista, udito, olfatto ecc. Ossia dà un significato a ciò che vediamo, udiamo, sentiamo. Alla fine, dagli stimoli vengono attivate svariate emozioni, tra cui gioia, paura, rabbia ecc. L’amigdala è come un sensore di allarme perché riconosce stimoli pericolosi e attiva risposte emotive immediate ed intense. Il compito della corteccia prefrontale è quella di regolare l’azione dell’amigdala e permettere reazioni affettive più equilibrate.
L’amigdala e le memorie inconsce
L’amigdala è un archivio di emozioni (Goleman,1996). Essa conserva anche ricordi ed esperienze ricche di emozioni che abbiamo vissuto in passato ma di cui non siamo consapevoli, cioè non ricordiamo. Infatti in certi momenti della vita ci può capitare di reagire alle situazioni in modo intenso e inspiegabile. Questo succede perché l’amigdala ha memorizzato quelle esperienze emotive, senza che la parte vigile del cervello, chiamata neocorteccia, ne “sappia qualcosa”. Queste sono le memorie inconsce delle nostre emozioni e dei nostri ricordi. Esse sono archiviate nell’amigdala e influenzano le nostre decisioni e le nostre reazioni di vita e quotidiane senza la nostra consapevolezza.
A riguardo, un aspetto particolarmente interessante è il ruolo svolto dall’amigdala nell’infanzia, quando diventa una sorta di deposito di ricordi delle prime esperienze emotive. In quel periodo, il legame affettivo con i genitori o con i caregiver ha un’influenza cruciale sulla costruzione della vita emotiva del bambino. Le interazioni, vissute in quei primi anni, lasciano una traccia duratura nei circuiti dell’amigdala.
Da adulti, però, è spesso difficile accedere consapevolmente a quei ricordi ed esprimerli con le parole. Questo perché nell’infanzia il sistema limbico, di cui fa parte l’amigdala, è maturo e attivo. Mentre la corteccia cerebrale e il linguaggio non sono ancora sviluppati. Queste ultime strutture sono importanti per la rievocazione dei ricordi e per la loro espressione linguistica.
La primordiale funzione dell’amigdala è stata quella di rilevare eventuali situazioni di pericolo o di minaccia e attivare comportamenti di attacco, di fuga o di blocco (Cozzolino, 2021). Ciò spiega il ruolo fondamentale che essa ha avuto nella scala evolutiva, dovendo garantire la sopravvivenza, quando la neocorteccia non era ancora sviluppata.
Dirottamento dell’amigdala
In condizioni di percepita minaccia, a volte, la reazione emotiva dell’amigdala è immediata, impulsiva e molto intensa. In questi casi, le forti emozioni generate dalla paura o dalla rabbia possono innescare reazioni violente o irrazionali. Esse avvengono senza il controllo della corteccia prefrontale, che viene bypassata. Ciò genera senso di colpa o di smarrimento in chi compie tali azioni, a dimostrazione del loro carattere impulsivo ed immediato.
In tali situazioni, si parla di sequestro neurale o dirottamento operato dall’amigdala. Purtroppo, questi sequestri neurali si verificano con discreta frequenza anche in situazioni meno problematiche, con conseguenze personali e soprattutto relazionali. Pertanto, il ruolo dell’amigdala è cruciale, da paragonare ad una sentinella psicologica che rileva ed analizza ogni situazione, per cogliervi potenziali pericoli.
Se da un lato questa azione di controllo è importante perché ci permette di affrontare adeguatamente reali situazioni di pericolo, in altri casi è dannosa. Questo si verifica quando la percezione del pericolo non è correlata alla gravità della situazione, e le reazioni che ne conseguono sono immediate e intense.
In merito a queste reazioni emotive e comportamentali il neuroscienziato LeDoux (2000) ha fornito una spiegazione neurobiologica. La sua scoperta ha permesso di individuare l’esistenza di una diramazione di fibre nervose che è parallela a quella che conduce gli stimoli sensoriali alla neocorteccia. Quelle fibre nervose, in questo diverso percorso, vanno direttamente all’amigdala. In questo modo viene aggirata la neocorteccia. I segnali che percorrono questa diramazione sfuggono pertanto alla regolazione emotiva e alla coscienza.
Cause e fattori predisponenti del dirottamento dell’amigdala
Le cause che possono contribuire al dirottamento dell’amigdala sono molteplici. Tra essi, dicevamo, vi è lo stress, le esperienze traumatiche passate ed attuali, l’esposizione ripetuta a stimoli che inducono paura (LeDoux, 2000). Ed infine la mancanza di regolazione emotiva. Elevati livelli di stress compromettono il pensiero razionale e la capacità decisionale. Questa situazione di iper-arousal, ossia di ipereccitazione fisica e psicologica, favorisce l’esplosione di forti emozioni con agitazione, tensione, ipervigilanza, aumentata reattività e comportamenti irrazionali.
Analoga situazione si sperimenta nel corso di eventi improvvisi, frustranti o dolorosi. In tali casi è necessario mettere in atto un adeguato e consapevole controllo delle emozioni per evitare che essi possano travolgerci. In altri termini, un’inadeguata capacità di regolare le emozioni può rendere difficile controllare l’influenza dell’amigdala sul processo decisionale, portando a risposte impulsive e irrazionali.
Altrettanto molteplici sono i fattori che predispongono o facilitano il dirottamento dell’amigdala. I fattori che influenzano il dirottamento dell’amigdala possono essere individuali e ambientali. Tra i primi, giocano un ruolo essenziale i tratti di personalità, le modalità di regolazione e gestione delle emozioni e alcuni processi cognitivi.
Gli individui che tendono a percepire le situazioni ambigue come minacciose potrebbero esserne un esempio (Pessoa, 2009). Allo stesso modo, coloro che tendono a prestare attenzione agli stimoli negativi potrebbero essere più inclini ai dirottamenti dell’amigdala (Bar-Haim et al., 2007).
Tra i fattori ambientali concorrono la mancanza di coinvolgimento e di supporto sociale , reali o percepiti, associati ad elevati livelli di stress e conseguenti comportamenti reattivi. Analoga influenza è dovuta a certe norme culturali o realtà sociali in cui anche la regolazione e l’espressione delle emozioni è vincolata a delle regole.
Conclusioni
Quando l’amigdala prende il controllo, dirottamento, proviamo emozioni forti e immediate. Questo porta a reazioni istintive che si rivelano spesso utili perché volte a difenderci o proteggerci. A volte, però, queste reazioni si rivelano impulsive e irrazionali, con conseguenze negative.
Si tratta di situazioni in cui, le due intelligenze razionale (neocorteccia) ed emotiva (amigdala e sistema limbico), che dovrebbero essere interconnesse, agiscono in modo indipendente. Quando questo avviene, come nel caso in analisi, si hanno diverse conseguenze come l’alterazione del processo decisionale, la mancata regolazione emotiva e le implicazioni relazionali. Infatti l’intensità e l’imprevedibilità dei dirottamenti dell’amigdala possono mettere a dura prova le relazioni interpersonali e influire sulle interazioni sociali.
Conoscere i meccanismi alla base del dirottamento dell’amigdala, le cause e i fattori predisponenti è essenziale. Questo al fine di attuare percorsi formativi centrati sull’educazione alle emozioni che affianchino e facilitino il corretto sviluppo anche della intelligenza cognitiva. Inoltre, conoscere il dirottamento dell’amigdala può portare a migliori relazioni interpersonali, capacità comunicative e benessere generale. Ma soprattutto è alla base di interventi mirati in quelle condizioni legate alla disregolazione emotiva, come disturbi d’ansia o problemi di gestione della rabbia, disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e disturbi dell’umore.
Enza Maierà
Bibliografia
- Cozzolino L., Neuroscienze per i clinici, Raffaello Cortina Editore, 2021
- Goleman D., Intelligenza emotiva, Bur Saggi, 1996
- LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. Annual review of neuroscience, 23(1), 155-184
- Bar-Haim Y, Lamy D, Pergamin L, Bakermans-Kranenburg MJ, van IJzendoorn MH. Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: a meta-analytic study. Psychol
- Bull. 2007 Jan;133(1):1-24. doi: 10.1037/0033-2909.133.1.1. PMID: 17201568.
- Pessoa L. How do emotion and motivation direct executive control? Trends Cogn Sci. 2009 Apr;13(4):160-6. doi: 10.1016/j.tics.2009.01.006. Epub 2009 Mar 13. PMID: 19285913; PMCID: PMC2773442.
- Orji, L. C., Ita, U. A. (2024), Amygdala Hijack: Contemporary Insights into Causes, Correlates and Consequences. African Journal of Health, Nursing and Midwifery 7(3), 102-111. DOI: 10.52589/AJHNMKQM0NM27
Foto: Envato Elements